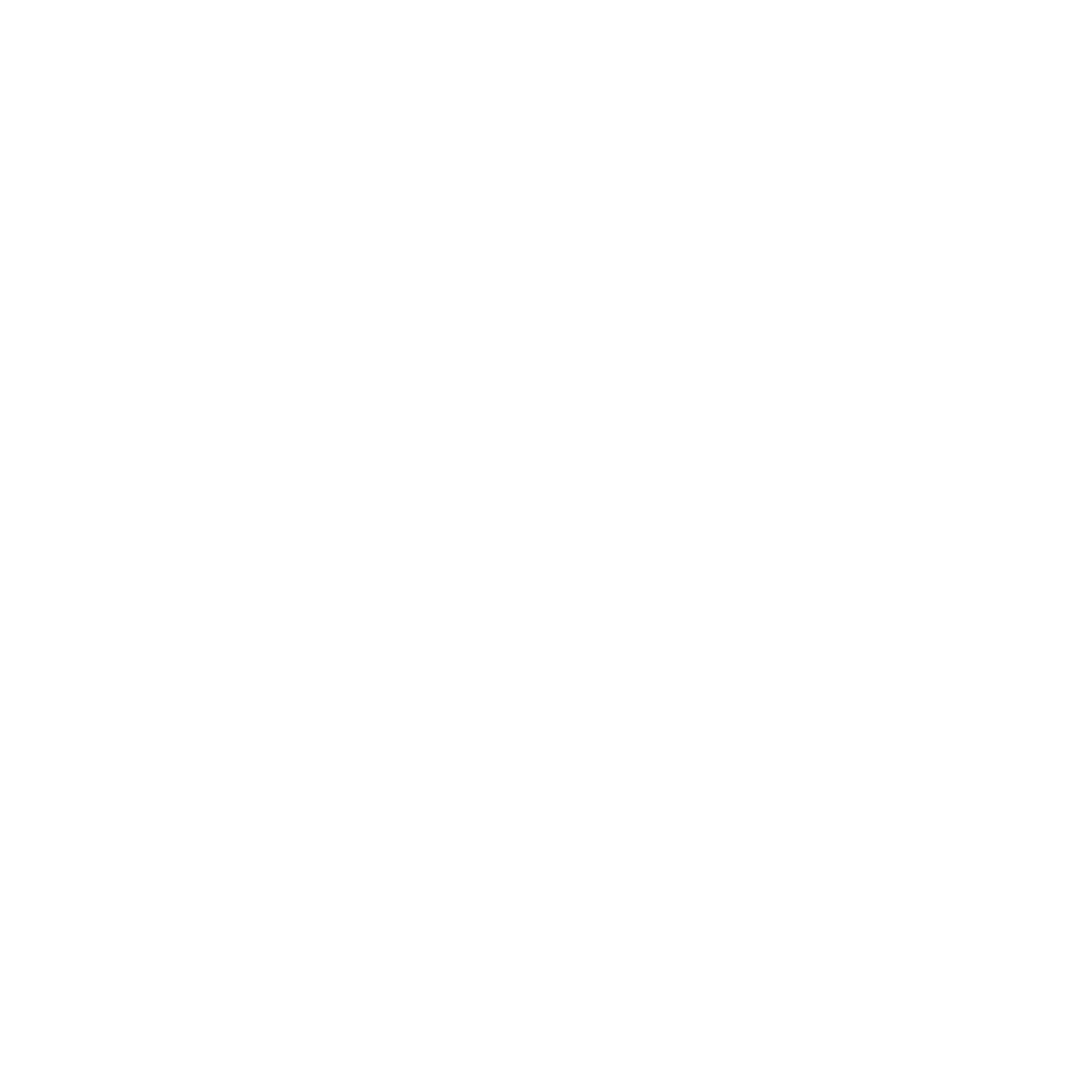Ogni volta che, al termine di una giornata, mi dico che tutto è andato bene e posso ancora permettermi di stare a Roma, mi sento in colpa.
Mi sento in colpa come se stare a Roma fosse uno status troppo lontano dalla mia realtà, come se potesse essere concesso solo a persone di grande merito, poeti, artisti, pensatori eroi. Mi rendo conto che Roma è esattamente tutto questo, la città nella città, il significato oltre le cose, oltre il suo tramonto così denso di sagome lasciate dal tempo, da un tempo così lungo che diviene il tempo. Mi rendo anche conto che non per tutti è così, non a tutti è concesso questo desiderio e non a tutti è concesso di vedere.
Roma è il tempo, il metro di misura di tutte le altre storie, di tutte le altre vite, il confine fra il prima, privo di voce, ed il dopo, da cui nascono tutte le voci.
In un’intervista, Jorge Luis Borges sostiene che a Roma non si sente trascorrere il tempo, si sente però il suo peso e poi ricorda Chesterton che disse che è avventato recarsi a Roma se non si ha la certezza di poterci tornare.
A volte la guardo negli ultimi momenti della sua giornata, distesa ai piedi delle sue terrazze, poi dei suoi colli, e infine dei suoi castelli, il suo profilo è una linea di arancio sul fondo di un cielo di miele, sento il peso del suo essere, da sempre e per sempre, tenendo tutte le antichità in equilibrio nella sua aria, fra le sue mura, tendo le mani per afferrarla, io sono Roma.